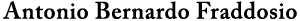18 Nov “Un mare di ghiaccio, le onde nere e l’alba di un nuovo inizio”
di Gabriele Simongini
“L’inverno non importa se ci saremo ancora
Davanti a noi i giorni le notti sfumano
La nostra memoria è un pesante relitto
Un balcone crollato il nostro avvenire
Denudiamo un corpo che si rispetta
La cui spoglia è un corpo vestito
In resistente amalgama d’ombra e di spazio”.
Paul Eluard (“A Raoul Ubac”)
Cartografie dello spirito
Un mare di ghiaccio, anzi, “Il mare di ghiaccio”. Da giorni, pensando alle opere di Antonio Bernardo Fraddosio, il ricordo di una qualche immagine, per molto tempo indefinita, affiorava e poi scompariva dalla mia mente, lasciando un senso profondo d’insoddisfazione per il mancato riconoscimento. Poi, durante l’ultima visita nei suoi due studi di Tuscania, quell’immagine da fantasma lontano si è svelata in tutta la sua potenza, come una rivelazione. Era uno dei sublimi capolavori di Caspar David Friedrich, “Il mare di ghiaccio” (1824; Amburgo, Kunsthalle), con quelle punte aguzze che svettano aggressivamente verso il cielo, nel dialogo fra bianchi ed azzurri, nel mare di silenzio di un paesaggio che evoca l’eternità divina nella quale restano imprigionati i poveri relitti di una nave affondata. Ora, mutatis mutandis, qualcosa di quel deserto ghiacciato, scavalcando due secoli, sembra tornare nelle corde extra-pittoriche di Fraddosio, con quelle deflagrazioni materiche che aggrediscono e segnano lo spazio con una specie di dolce violenza che attrae ed al tempo stesso mette in stato d’allarme l’osservatore. Come scriveva Aby Warburg, “il presente è intessuto di passati multipli” e l’arte è percorsa da “fantasmi per adulti”, cioè da risvegli di immagini che si alternano al loro sonno: ai miei occhi qualche eco de “Il mare di ghiaccio” si propaga nelle sculture del nostro artista. Ecco, quell’opera di Friedrich e i lavori di Fraddosio (basta pensare a “Sconnessione” oppure a “La materia del tempo”, solo per fare due esempi), senza voler fare paragoni azzardati e fuori luogo in termini di intensità, lasciano però affiorare una sorta di comune concordia discors, la capacità di unificare elementi opposti facendoli vivere l’uno nell’altro senza separazioni concettuali. Sia “Il mare di ghiaccio” di Friedrich che le opere di Fraddosio sono, in qualche modo, cartografie dello spirito fatte di avvallamenti, anfratti, dirupi, sentieri interrotti, crepacci, pendii dilavati. In Friedrich la finitezza dell’uomo convive con l’infinito della natura, la solitudine individuale cerca un dialogo con l’armonia dell’universo, un senso panico del mondo si rispecchia nell’afflato divino. In Fraddosio, la costruzione è anche distruzione, la struttura è destrutturata, la nascita del nuovo implica la fine esplosiva del vecchio, lo spazio è concavo e convesso, la vitalità convive con un profondo senso di disfacimento, la speranza con la disperazione, l’aspirazione ad un volo liberatorio porta con sé la paura della caduta. “Se un albero fiorisce – scriveva Rilke – fiorisce la morte in esso come la vita, e il campo è pieno di morte, che dal suo volto supino germoglia una ricca espressione di vita, e gli animali trapassano pazienti dall’una all’altra”.
Cantieri della crisi
Nel novero degli artisti oggi emergenti con forza, Fraddosio dà corpo più che immagine, vista la fisicità dei suoi lavori, ad un’idea profonda di crisi relativa alla nostra epoca, alla necessità di una scelta fra ciò che sta crollando e quello che sta faticosamente emergendo in modi ancora indistinti e faticosi. “Crisi delle utopie, crisi dei progetti, crisi dei modelli – ha scritto Yves Michaud con parole che Fraddosio potrebbe ben condividere- perfino crisi della storia divenuta finzione. Dal punto di vista collettivo, il capitalismo e la globalizzazione sono ormai l’ambiente, senza esterno, in cui ci tocca vivere.[…] Il tempo si è per così dire appiattito: non comporta più la dimensione di un fine ultimo che faceva luccicare il futuro”. Eppure, nelle opere “critiche” di Fraddosio, così colme di tensioni, torsioni, compressioni (si intitola “Compressioni esplosive” un bellissimo lavoro del 2008 in cui dal relitto di una finestra sembrano staccarsi con fatica due ali d’angelo minacciate da una tensione esplosiva), connessioni e sconnessioni, fratture ed imprevisti ricongiungimenti, il bianco generato in modi diretti dalle diverse materie ha una valenza quasi kandinskiana, porta con sé il “silenzio della nascita”, dopo il fragore della fine. L’ombra e la luce restano quasi intrappolate in questi assemblaggi scultorei, rincorrendosi senza sosta, annidandosi in un anfratto o emergendo con forza da un elemento in poderosa tensione, adagiandosi su una superficie opaca o riflettendosi su un frammento lucido. Pare così di entrare anche fisicamente in una dimensione che prelude all’alba di una nuova epoca e forse lo spettatore prova quasi il desiderio di aggrapparsi a questa specie di zattere pericolose, aguzze ma dotate di un’intima spinta dinamica. Sono opere da affrontare fisicamente e psicologicamente e non tanto da contemplare, quanto da vivere come un’esperienza, in piena sintonia con le ricerche contemporanee più convincenti. L’estrema “fisicità” di questi lavori impone un confronto diretto che sembra contrapporsi con forza alla virtualità e alla smaterializzazione oggi imperante. Ne promanano un desiderio di sostanza e una tensione verso la ricerca di nuovi valori che per certi versi già entrano in sintonia con quella “Età dell’Autenticità” di cui ha recentemente parlato lo scrittore inglese Edward Docx e che potrebbe finalmente sostituirsi al postmodernismo.
In un cortocircuito continuo, elettrizzante come una scarica di energia, l’artista sembra spingere percettivamente fuori dalla superficie dell’opera l’osservatore con le forme convesse per poi invitarlo immediatamente a entrarvi dentro con quelle concave, quasi senza soluzione di continuità ma comunque suggerendo un ritmo percettivo che deve svolgersi nel tempo senza esaurirsi nel puro e semplice colpo d’occhio. Nella dialettica fra unità e varietà di questo percorso, le opere del nostro artista, viste da una certa distanza, sembrano muri, pareti impenetrabili. Viceversa, avvicinandosi, si avverte con forza una pluralità di possibilità e di aperture, di ipotesi vitali e di emergenze immaginative. L’opera si dà e si nega al tempo stesso, da muro diventa porta e soglia che separa il visibile dall’invisibile. Diventa un organismo plastico che fa incontrare spazio interiore e realtà esteriore, accomunati in una nuova identità. Lo spettatore è libero di rimanere tale guardandoli da una posizione rigorosamente esterna e quasi asettica ma questi lavori svelano tutta la loro carica esplosiva quando si ha il coraggio di mettersi in gioco, percorrendoli con lo sguardo e con le mani fino alle viscere e scoprendo infiniti punti di vista, imprevisti, che li rendono sempre diversi, metamorfici e sorprendenti.
Lo si vede bene nell’opera fondamentale presentata nel Padiglione Italia (Arsenale) alla 54° Biennale di Venezia, “Bandiera nera nella gabbia sospesa” (metallo ossidato, fibrolegno modellato, cemento, catrame), che reclama di essere agitata, cullata e ruotata, quasi divelta per liberare quel vessillo prigioniero che è un po’ l’anima di ognuno di noi. Con un amaro paradosso, l’unica che può sventolare muovendosi nello spazio è quindi la gabbia mentre la bandiera è condannata a vivere del riflesso di quel movimento e giace immota come un animale costretto tra le sbarre. Così il minimalismo assertivo della gabbia esalta per contrasto quel vessillo combusto e annichilito, emblema inquietante di resa ed impotenza collegabile forse alle molteplici crisi del nostro tempo. Nella contrapposizione fra costrizione ed aspirazione alla libertà, tornano alla mente queste riflessioni di Paul Klee: “L’uomo è per metà prigioniero e per metà alato. Ognuna delle due parti in cui è lacerato il suo essere, accorgendosi dell’altra, prende coscienza della propria tragica incompiutezza”. E non a caso l’ombra gettata dall’opera sul pavimento sembra visualizzare un essere alato che sta per uscire dalla sua prigione, con un effetto quasi teatrale che non si può fare a meno di mettere in rapporto con la prolifica attività di scenografo del nostro artista. La “Bandiera nera nella gabbia sospesa” ha il suo alter ego nell’ombra, con l’ipotesi di un possibile finale, come in uno spettacolo teatrale concluso da un enigmatico punto interrogativo. Così, nei suoi esiti recentissimi esemplificati al livello più alto proprio in quest’opera, Fraddosio mette in campo un rapporto sempre più attivo e coinvolgente con la dimensione ambientale ed installativa, la più adatta, sotto certi aspetti, per mettere in stato di allerta critica visitatori abitualmente anestetizzati da un bombardamento incessante di immagini ipnotiche. Restando fedele al proprio linguaggio sismico e destabilizzante, il nostro artista non si chiude mai nella turris eburnea del gioco formale fine a se stesso, proprio perché prende atto ed in qualche modo registra le scosse che agitano la nostra società e ne innerva le proprie opere con una mirabile osmosi fra forma e contenuto in cui l’intento simbolico si fa tutt’uno, inestricabilmente, col fatto plastico senza mai prevalere freddamente ed isolatamente.
Partito da un profondo studio della spazialità dinamica barocca (soprattutto Borromini) e da una chiara eredità informale (Burri in particolare ma anche i “frammenti di forme” costruite su potenti torsioni e tensioni di forze di Francesco Somaini) poi superata con una riflessione sull’attraversamento e il superamento della superficie della tela, verso altre dimensioni, portati avanti da Fontana, in primis e quindi da Manzoni, Castellani, Scarpitta, Scheggi, tra gli altri, Fraddosio per molti anni ha cercato con inesausto rigore la propria strada intimamente necessaria. Pur meditando attentamente sull’integrità oggettuale e plastica delle fasce in tensione di Scarpitta e sul minimalismo dei pionieristici ferrocementi di Giuseppe Uncini, il nostro artista ha avvertito la loro misurata appartenenza all’iniziale boom economico di un’Italia positiva ed ottimista e comunque ad una nascente “cultura dell’oggetto”. Fraddosio sente invece con forza la complessità dell’odierna civiltà del flusso, dell’instabilità, della frammentazione e così, emblematicamente, fa esplodere con una tensione profondamente espressionista le bande di Scarpitta e le strutture di Uncini, dando corpo plastico ed ambientale al suo “cantiere della crisi”: lo si vede bene, ad esempio, nel potente frammento di un’opera come “Torsioni”. Egli ha infatti individuato un topos della nostra epoca nell’immagine dei ruderi metropolitani, dei cantieri interrotti, delle “grandi” opere incompiute e lasciate per decenni a perenne memoria dell’inutilità e del deturpamento ambientale: le rovine di tante Torri di Babele contemporanee finite nel nulla. Ne è emblema scarnificato e visionario un’opera come “Ruderi metropolitani”. Così Fraddosio si sta liberando dai riferimenti precedenti e tutti interni all’ambito artistico per volgersi verso un personale “reportage” sulla crisi e sull’incompiutezza che ci circondano concretamente e non solo simbolicamente. Le fratture che percorrono come terremoti la superficie delle sue opere mettono a nudo le crepe nascoste di un modo di vivere asettico, indifferente, anestetizzato. Le sue antiarchitetture destabilizzanti, fatte anche di umili materiali di recupero e prive di qualsiasi levigata compiutezza, fanno emergere il ritratto di un mondo che deve ormai fare i conti col proprio malessere più profondo, quello esploso con la crisi economica, la rivoluzione delle piazze arabe, la rivolta nelle periferie londinesi, ecc. Un mondo praticamente inabitabile come le opere di Fraddosio, disintegrato in mille frammenti alla deriva e privo della luce di qualunque faro consolatorio. E in tal modo le metamorfosi del frammento, così potenti e radicate nella nostra contemporaneità che si nutre voracemente di frantumazioni, vengono esaltate da Fraddosio con una consapevolezza che trova un rispecchiamento in quel che Salvatore Settis ha più volte sottolineato: “ […] (come scrisse Paul Valery) il frammento ha in sé una invincibile necessità, il germe di qualcosa, “qualcosa che vale di più di un significato, la spinta ossessiva ad essere completato”, la perentoria eloquenza dell’incompiuto. La condizione di frammento intensifica il senso, acuisce lo sguardo dell’osservatore; insomma, è “moderna”. Nonostante ciò, la vocazione costruttiva di queste opere è testimoniata anche dal fatto che esse non riempiono banalmente lo spazio ma lo generano di volta in volta con esiti sempre diversi. Questo percorso trova una perfetta rispondenza nelle riflessioni di Michel de Certeau (in “L’invenzione del quotidiano”, 1980): per resistere alla drammatica alienazione della vita urbana, è necessario “articolare una geografia seconda, poetica”, in cui sia fondamentale cercare “le reliquie del senso e talvolta i loro scarti, i resti capovolti di grandi ambizioni”. Ecco, Fraddosio svela anche il fallimento del sistema dominante, nella vita e nell’arte, fondato sul mito della produzione, dell’efficienza, del consumismo.
Inoltre il prolifico connubio fra costruzione e distruzione di questi lavori evoca anche una sorta di “messa in scena” senza tempo dell’idea di rovina che non può non richiamare alla mente il profondo legame dell’artista con Roma, “un luogo in cui il tempo si disintegra”, per dirla con le parole di Henry James. La città in cui, come scriveva Goethe nel suo “Viaggio in Italia”, “si trovano tracce di una magnificenza e d’una distruzione che oltrepassano entrambe la nostra immaginazione. Quello che i barbari hanno lasciato in piedi, hanno devastato gli architetti della Roma moderna…Questa gente lavorava per l’eternità; e teneva conto di tutto tranne che della follia dei devastatori, alla quale tutto deve cedere”. Sono parole attualissime, anche pensando a quel che avviene tutt’oggi nella Città Eterna e che certo non sfugge ad un artista sensibile come Fraddosio, particolarmente attento alle emergenze dell’architettura e dell’urbanistica contemporanea nel difficile dialogo fra salvaguardia dell’antico ed esigenze di una metropoli del XXI secolo.
Eppure, c’è ancora qualcosa di più che si lega ad una sorta di tensione organica, in quelle forme che si girano e si torcono, si annodano e si snodano sotto l’impulso di uno sforzo ancestrale, di un desiderio primordiale, come tronchi di vite e edera intrecciati che traggono dal cuore della terra il nutrimento e l’appoggio. In questo senso negli esiti più convincenti della sua ricerca c’è un’unità vivente che si radica nelle emergenze critiche della nostra epoca ma che trae linfa pure da sommovimenti vitali ed archetipi. Architetto, scultore, pittore e poeta, Fraddosio padroneggia ed unifica una polifonia di tecniche e di strategie creative capaci di sintonizzarsi anche con quella compresenza delle differenze e con quel pluralismo che danno l’immagine più “riconoscibile” all’arte del nostro tempo.
La sua attività demiurgica fonde completamente la tensione immaginativa con l’elaborazione manipolativa della materia, nel senso a suo tempo indicato da Henri Focillon: “le materie comportano un certo destino o, se si vuole, una certa vocazione formale […] Possiamo dedurne una regola più generale, che si collega al principio del destino o della vocazione formale enunciato dianzi: cioè che le materie dell’arte non sono intercambiabili, vale a dire che la forma, passando da una materia ad un’altra, subisce una metamorfosi”. E in effetti Fraddosio, nel suo creativo cantiere aperto sulla crisi del nostro tempo, ha individuato e messo in opera materie assai diverse che hanno a che fare con l’idea di costruzione edilizia ed urbana (di origine fossile come l’asfalto liquido e il catrame o di origine calcarea come il cemento), con la natura (l’acqua, il legno e i lapilli), col linguaggio artistico (la pittura acrilica, la carta e il gesso), con una contaminazione arte-natura-metropoli che corrisponde perfettamente anche dal punto di vista tecnico e materico agli obiettivi della sua ricerca.
Le carte
Nelle carte, poi, la devastazione e l’usura della superficie nascono emblematicamente dall’incontro-scontro fra materie “organiche” e materie chimiche, i cui colori reali e mai artefatti danno vita all’opera. A questo proposito suonano quanto mai attuali le parole di un inquieto visionario come Goya: “Nella natura, il colore non esiste più della linea; datemi un pezzo di carbone e vi farò un quadro; perché tutta la pittura è nei sacrifici e nella decisione”. Dalle carte di Fraddosio promana una “verità” interiore che combacia con un’immemorabile “storia naturale infinita” (per dirla con Klee) e che si deve anche alla rinuncia al pigmento pittorico in senso rappresentativo per cercare una personale alchimia della materia che coincida con i più intimi stati della coscienza dell’artista. In tal senso per le sue carte Fraddosio potrebbe ben condividere quanto ha scritto Vasco Bendini: “i miei quadri sono la materializzazione del mio pensare, sentire, immaginare, intesa come un vero e proprio calco della gestazione di una serie di eventi della mia coscienza. Questa costante attenzione al processo di formazione delle immagini, strutture, relazioni della mia mente, attenzione che si traduce in immagini pittoriche, ripropone, attraverso tali simboli figurali e sintattici, il flusso ininterrotto del mio processo mentale”.
In queste opere Fraddosio deve comunque misurarsi con un supporto bidimensionale che riduce le possibilità di espansione plastica ed ambientale permesse dalle sculture ma ciò favorisce anche una sorprendente ampiezza di soluzioni e variazioni intorno allo stesso motivo: almeno in un paio di carte (“Trama nera” e “Linea d’ombra”) pare già di scorgere come in una visione il reticolato della gabbia e la bandiera nera che danno vita all’opera attualmente presentata alla Biennale di Venezia. L’aprirsi sul piano bidimensionale di forme-materia che si squadernano liberamente e senza alcuna volontà rappresentativa ci conduce in un’altra dimensione rispetto al lavoro di Venezia, un ambito più intimamente visionario e raccolto ma completamente lontano dall’idea di progetto. Così le carte, nel percorso di Fraddosio, sono micromondi in sé autonomi e pur dialoganti con i ruderi metropolitani di cui per alcuni aspetti finiscono con l’essere l’alter ego bidimensionale e cosmogonico.
Inseguendo il difficile
In ogni caso la vocazione creativa del nostro artista è essenzialmente “antipittorica”, rifuggendo l’uso del pigmento cromatico tradizionale e delimitando la sua ricerca entro gli estremi opposti del bianco e del nero, i cosiddetti “non colori”, a cui si aggiunge in alcune opere recenti il grigio. Sia nelle carte che nelle sculture, al di là di qualsiasi schema concettuale che accomuna la scelta della materia ad un’idea, l’opera nasce esclusivamente dalla totalizzante azione psico-fisica di Fraddosio che proprio per questo lavora senza progetto privilegiando il conflitto purificatore con la materia nato da un impegno illimitato e privo di remore: “Soltanto combattendo – spiegava Ingres – si acquista qualche cosa e, nell’arte, il combattimento è la fatica che si fa”. Come pareti da scalare con un’arrampicata del più alto grado di difficoltà, le sue opere sono innervate da una vocazione alla fatica che rinnega qualsiasi facilità esecutiva per mettere in luce ciò che è difficile e che vale la pena di essere inseguito con ogni sforzo: “ La gente (con l’aiuto di convenzioni) ha dissoluto tutto in facilità – scriveva Rilke e Fraddosio può ben condividere queste parole – e della facilità nella più facile china; ma è chiaro che noi ci dobbiamo tenere al difficile; ogni cosa vivente ci si tiene, tutto nella natura cresce e si difende alla sua maniera ed è una cosa distinta per sua virtù dall’interno, tenta d’essere se stessa ad ogni costo e contro ogni resistenza. Poco noi sappiamo, ma che ci dobbiamo tenere al difficile è una certezza che non ci abbandonerà; è bene essere soli perché la solitudine è difficile; che alcuna cosa sia difficile dev’essere una ragione di più per attuarla”.
Ogni intuizione del nostro artista si concretizza, attraverso un concentratissimo pensiero corporeo, nella scelta di materie precise e trae impulsi sempre nuovi dalla loro stessa natura oltre che dal processo operativo mantenuto costantemente aperto alla sperimentazione ed all’intervento improvviso, alla felice e rischiosa precarietà del gesto e dell’azione. Oggi l’arte, relegata in una marginalità ininfluente, ridotta a puro e semplice investimento economico e trasformata in ancella dello strapotere mediatico ed iper-tecnologico, non può consolare né promettere la felicità, ma può cercare di scuotere alcune coscienze iniettando l’antidoto del senso critico e prospettando la possibilità di un mondo diverso e tuttavia ben radicato nel terreno della vita. “L’arte – scriveva Rabindranath Tagore – non è un fastoso sepolcro perduto nel sogno immutabile di una eternità solitaria di secoli svaniti. Essa appartiene al procedere della vita, e si adatta costantemente alle sorprese che l’assalgono, esplorando santuari di realtà sconosciuti lungo il suo pellegrinaggio verso un futuro tanto differente dal passato quanto lo è l’albero dal seme”. Ecco, Antonio Bernardo Fraddosio si è incamminato su questa via.
Gabriele Simongini