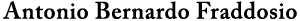08 Dic “Materia dell’arte come impegno etico”
di Claudio Crescentini
«Un uomo. Tutto quello che è successo è stata colpa di un uomo».
Jonathan Lethem, Il giardino dei dissidenti, 2014
La materia si flette e avvolge su sé stessa, come se fosse stoffa, fingendo anche la pelle ma non è pelle ringraziando Dio e non è stoffa. É materia, lamiera d’acciaio modellata, trasformata dalla mano dell’uomo in un panneggio antropomorfo.
Non ci sono mai stati uomini dentro le tute d’acciaio flesse da Fraddosio, ma ci sono uomini che utilizzano tute simili, non d’acciaio ma di stoffa che contengono il corpo, la pelle, di un uomo.
Ma la materia finge altro, provoca l’estetica per invadere l’etica, l’impegno, la coerenza di un rapporto con l’esterno che non vuole essere più pura pratica creativa. E l’arte diventa altro, piena coscienza di un rapporto con la realtà, emozione, cronaca del presente che sarà storia, che è già storia. La nostra.
L’arte torna così a non rifare sé stessa ma a guardare a ciò che succede intorno e l’artista non è più – non può più esserlo– demiurgo e guru di teorie metafisiche ma protagonista preciso e attivo del suo – nostro – presente, proprio come nella vivida operatività fisica e visiva di Antonio Fraddosio e dell’installazione “Le tute e l’acciaio” (2018).
Fraddosio, nell’opera appositamente realizzata per i suggestivi spazi seicenteschi della GAM di Roma, lavora sulla cronaca decennale dell’Ilva annodando le fila di un confronto con il tempo e i tempi del presente. Dalla cronaca di una città, Taranto, e quindi di una nazione, passando per i riscontri con i suoi ricordi di gioventù. A Taranto appunto, prima e durante l’Ilva. Ma sarà così anche dopo.
Dalla memoria al dramma quotidiano. Dal contesto drammatico di un «lavoro che uccide», come l’ha descritto Nicola Logioia, al percorso artistico coerente di Fraddosio che dopo le opere dedicate ai migranti, alla tutela dei diritti umani mondiali, alla crisi morale dell’uomo occidentale, agli egoismi dei singoli nazionalismi, torna ad esporre a Roma con un nuovo messaggio artistico e antagonista che è anche acuto riscontro dell’impotenza politica. Una delle tante nel mondo.
In sincerità ci siamo persi nelle tante e contorte vicende della cronaca sull’Ilva, nelle diverse soluzioni pratiche – realizzate e/o solo ipotizzate – della politica e dei tecnicismi di questa stessa, anche perché poi quello che rimane veramente è il senso di impotenza di una società rispetto ad un dramma protratto per decenni e che Fraddosio trasforma in arte.
Arte d’impegno, arte-azione che dalla materia contemporanea deduce appunto l’azione e la trascrive in materia, rendendola viva come nei cassoni di cor-ten ossidato utilizzati dall’artista, i quali e contengono – costringono – al loro interno gli acciai incartati e pressati da Fraddosio.
Acciai lavorati e infiacchiti dall’artista che diventano strutture primarie e materie ossidate che, a loro volta, rimandano, così come lo stesso artista suggerisce, al quartiere “dei Tamburi” di Taranto. Per capirci quello limitrofo all’Ilva.
Costretti fra la vita, il lavoro ma anche la morte quotidiani, il quartiere è il simbolo generazionale di una resistenza passiva che Fraddosio trasforma in materia viva e pesante. Rosso ruggine come le polveri velenose che soffocano il quartiere, la città, in contrapposizione con i pannelli di ferro nero, impiegati come piano di fondo, sporcati di ossido e di acidi. Su questi sono deposte le lamiere lacerate, incendiata dall’artifex che usa l’arte per dire altro. Per pensare e fare pensare “ad altro”. Anche se poi quell’ “altro” riguarda la nostra realtà quotidiana. Il dramma di una città che è dramma di una nazione.
In primo piano, le lamiere d’acciaio, strutture emozionali che sono realtà viva, drammatica, con inserite quelle sigle in ferro trattato che non sono ermetismo ma numeri atomici degli elementi che compongono le polveri inquinanti di emissione. La morte reale – non d’arte – intorno all’Ilva.
La reazione diventa azione artistica e pensiero antagonista dell’artista/uomo completamente immesso all’interno di una realtà sentita, vissuta in cui si costringe e ci costringe. Proprio come quei tubolari in ferro ossidato che chiudono lo sguardo del visitatore della GAM e gli precludono la visione aperta, in alto, del cielo. Struttura che imprigiona lo sguardo e quindi il cielo verso cui si apre il chiostro/giardino del museo.
Continua è quindi la compenetrazione di piani di visione e di ellissi di lettura, dove energico rimane l’impatto vivo della materia e il contrasto di questa con il contenitore espositivo. Un contrasto cercato e voluto che crea spessore e prodotto, quasi senza concedere niente alla riflessione.
La realtà è troppo viva e opprimente per lasciare spazio al tempo della riflessione e Fraddosio lo sa e utilizza il senso di oppressione trasformandolo in percorso visivo, prospettiva strutturale.
L’artista in questo modo, nel continuo percorso di rimandi e concezioni, giocati anche su vari stadi semantici, propone una storia di ieri che è ancora di oggi, sperando che non sia “di domani”.
Lavora la materia oggettiva con vigore espressivo, manipolando la materia nuova, contemporanea eppure antica, a tratti anche in maniera ambigua, riproponendo, come ormai fa da anni, quella “poesia della materia” e del dramma sociale che gli è molto cara. Una materia evocativa seppur reale quella di Fraddosio, tanto che l’installazione “Le tute e l’acciaio” non resiste alla tentazione di trasformare l’ideologia dell’impegno in una faccenda di “visione privata”, museale appunto, e a tratti, lo ripetiamo, poetica. Nonostante l’argomento.
Ma del resto Fraddosio ci ha ormai abituato a un’arte che, seppur tratta dalla realtà, viene elaborata e assoggettata senza mai perderne il valore d’impegno, svelandone in più il tratto poetici. Anche dove poesia non c’è.
Claudio Crescentini