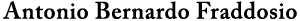19 Nov “Le tute e l’acciaio”
di Michele Ainis
Ti guardano senz’occhi, né labbra, né sorriso. Sono le forme scultoree di Antonio Fraddosio, lamiere accartocciate su pannelli di ferro, però al contempo aeree, sospese a mezz’aria, senza un centro di gravità che ne sorregga il peso. Sono anche corpi, perché del corpo umano riflettono il movimento interno, quell’energia che si comunica all’esterno, finché c’è vita, finché lì dentro pulsa il desiderio. Ma sono vive o morte queste figure informi? C’è una scintilla vitale in questa galleria di metalli corrosi dagli acidi, bruciati dalla fiamma, chiazzati dalla ruggine, martoriati dalle mani dell’artista? La risposta è sì, la risposta è anche no. La loro immagine cattura il tempo di passaggio nel quale l’ombra prende il sopravvento sulla luce, ciò che esiste diventa ciò che è stato.
È la cifra distintiva di Fraddosio, la sua capacità d’imprimere una forma allo sformarsi, alla dissoluzione delle cose. Un tratto che ricorre in tutto il suo lavoro, nelle opere scultoree così come in quelle pittoriche. Anche se Fraddosio, quando dipinge, non dipinge, non usa mai il colore: assembla piuttosto i cromatismi dei vari materiali depositati sulla tela o sulla tavola, senza sovrapporvi, col pennello, alcuna coltre artificiale. C’è infatti una verità nella materia, nelle diverse materie usate dallo scultore o (più raramente) dal pittore: legni, gessi, stucchi, cementi, cartoni pressati, ferri, resine, garze, reti metalliche, intonaci, catrami. E pietre, per metà grezze per metà scolpite.
L’elemento unificante delle sue costruzioni risiede perciò in una decostruzione, in una destrutturazione. La struttura è il reale, per come si manifesta al nostro sguardo: una superficie levigata, con un ordine che attinge dalla razionalità dell’intelletto. Però al di sotto pulsa un braciere d’istinti e d’emozioni, e c’è in ultimo la morte, prima e dopo ogni esistenza. Anzi: il nostro stesso stare al mondo non è che un’eccezione rispetto al tempo eterno della morte, e l’eccezione dura un battito di ciglia, giacché lungo la corsa dei millenni e delle ere geologiche noi non ci siamo, non siamo stati, non saremo.
Ecco, Antonio Fraddosio è un poeta dell’oscurità, delle tenebre, o meglio dell’ottenebrarsi, termine che poi rimanda a una corruzione della mente, a un disturbo percettivo. Sarà per questo che i suoi lavori viaggiano sulle diverse tonalità del grigio, del bianco, del nero, senza mai accendersi in una vampa di colori più sgargianti, senza illuminarsi, se non d’un lucore appassito. Sarà per questo che Fraddosio ha sempre intitolato le proprie opere come altrettante malattie dell’anima: Sfibramenti, Distacchi, Torsioni, Scissure, Fratture, Sconnessioni. O forse sarà che il poeta è anche un minatore, scava nel profondo, e sotto la crosta il mondo è un pozzo scuro.
C’è valenza politica nelle sculture di Antonio Fraddosio? Di certo ce n’è l’intenzione: lui è un uomo segnato dall’idea del comunismo e poi dalla crisi di tutte le idee, nel tempo inerte e vuoto che stiamo attraversando. C’è un’intenzione politica nelle Dieci tute di ferro esposte adesso a Roma, per la prima volta, presso la Galleria d’arte contemporanea Roma Capitale: giacché quelle tute, dedicate a ciascuno dei metalli che compongono le polveri di emissione, sono l’abito indossato dagli operai dell’Ilva, a Taranto, per difendersi (invano) dai tumori. C’era un’intenzione politica nelle opere che Fraddosio ha via via creato per rendere omaggio alla Costituzione italiana (in ultimo Demos Cratos e La grande Carta), denunziandone al contempo il tradimento. Ci fu un’intenzione politica nel ciclo intestato ai Resistenti (Louise Michel, Amilcare Cipriani, Giuseppe Gracceva, Pietro Cocco, Giacomo Corcella), uomini sconosciuti ai più, che si spesero per i poveri e gli oppressi. Ed era altresì politica, tutta politica, l’ispirazione da cui prese forma La bandiera nera nella gabbia sospesa, presentata alla 54ª Biennale di Venezia: la bandiera simboleggia l’ideale, la gabbia è l’emblema del potere che lo tiene in catene.
Ma dopotutto ogni artista è un politico, un uomo della polis, attento ai suoi destini. E d’altronde l’arte – diceva Picasso, e ama ripetere Fraddosio – non è fatta per decorare gli appartamenti, è invece lo strumento d’una guerra difensiva e offensiva contro il nemico. Una guerra combattuta con gli strumenti specifici del lavoro artistico, col suo linguaggio obliquo, indiretto, evocativo, che tuttavia può rappresentare il mondo con maggior precisione dei discorsi più precisi, che può colpirti come un pugno sullo stomaco ben più dei ragionamenti che ti propinano i saggisti. Perché l’espressione artistica costituisce uno strumento privilegiato di conoscenza, un veicolo di verità, quel poco di verità che ci è concesso d’esplorare. E perché «l’arte non parla se non di cose assenti», come disse Valéry. La sua stessa esistenza lascia infatti balenare la possibilità d’un ordine diverso da quello in cui siamo immersi, ed esattamente in ciò risiede la sua forza sovversiva, nella protesta contro il principio di realtà, che per lo più ci rende schiavi. Da qui l’aforisma di T.W. Adorno: «ogni opera d’arte è intrinsecamente rivoluzionaria».
Eppure la forza politica dell’arte non sta mai nella sostanza, bensì esclusivamente nella forma. Dipende dalla felicità espressiva degli artisti, non dal soggetto che ciascuno sceglie di rappresentare. E i polittici di Antonio Fraddosio ne offrono la prova. Sono possenti, vigorosi, però la loro forza discende dall’eleganza formale con cui l’artista scolpisce i materiali, dalle torsioni che vi imprime, dalle strutture curvilinee che ne disegnano l’ossatura, dalle superfici granulose in cui si sfalda la durezza del legno o del ferro o della pietra. Nel suo percorso artistico qualcuno ravviserà le tracce di Burri, qualcun altro l’ascendente di Manzoni. Analisi legittime, del resto siamo tutti nani sulle spalle dei giganti. Ma in ultimo il tentativo di Fraddosio è lo stesso che impegnò Italo Calvino, è lo sforzo descritto nella chiusa delle Città invisibili: «cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio».
Michele Ainis